Ma di che parliamo, allora, quando parliamo del lavoro com’era? La nostra costituzione pone questo termine addirittura a premessa della sua stessa identità, ma in Italia ogni lavoro è diverso dall’altro, il che significa soltanto che le regole le si inventano volta per volta. Alcune di queste sono consuetudinarie e tacitamente rispettate da tutti (come la regola del “fuorigioco”, per chi l’avesse realmente capita), altre si contrattano continuamente (come i diritti) ed evolvono secondo il principio biologico del “pesce grosso mangia quel che può”. Ma queste sono cose che non possono cambiare, e non valgono soltanto per il mio lavoro.
Il mio lavoro, come lo conosco io, è proprio di un genere che cambia spesso pelle per restare, sotto sotto, sempre uguale. Chi lo fa ha imparato ad apprezzare le sottigliezze: impiegati e freelance, a spasso e salariati, a progetto o in prova. Ci piace cambiare e aggiornarci. L’arte del curriculum ha soppiantato da tempo quella dell’origami per chi ha molto, molto, tempo da perdere. Ma ognuno del proprio tempo fa quel che vuole. Certo, io posso parlare per me. Anzi, quando ne ho l’occasione, lascio parlare Luciano Bianciardi, che con la sua Vita agra ha davvero impresso a fuoco “il” libretto nero delle professioni culturali in Italia: e, se siamo onesti, dobbiamo riconoscere che non è poi cambiato un granché, dal boom del dopoguerra alla nostra eclissi dell’Occidente tutt’ora in atto. Ma la bibliografia è sterminata e, nell’accezione sentimentale, del tutto disomogenea. Ognuno aggiunga i propri classici: Bernari di Tanto la rivoluzione non scoppierà, il petrolio di Pasolini, i diari di Flaiano, la perfetta sintesi del cretino di F&L, l’operaismo cibernetico di Calvino, la futura memoria nera su nero di Sciascia ecc.
Ho usato poco sopra l’espressione “professioni culturali”, devo confessare che con tutta probabilità si tratta di una delle tante improprietà linguistiche (tipiche delle professioni che hanno a che fare con la manutenzione della lingua) su cui mi incaponisco fino a ritenerle “perfettamente calzanti” rispetto a quello che voglio dire (e amen). Eppure Economia cognitiva, precariato intellettuale, operatori della comunicazione, terziario avanzato ecc. non fanno per me, non sono davvero adeguati a interpretare lo spirito, l’essenza, del lavoro in editoria, per come lo conosco, quindi continuerò, per il momento, a riferirmi alla mia come a una delle tante “professioni culturali” instabili che garantiscono l’equilibrio del nostro sistema. Avrei potuto anche lasciarmi sedurre da qualcosa del tipo “operaio della cultura”, ma suona stucchevole, o troppo sospetto di carica ideologica passatista, o manifestamente troppo snob persino a scopi elettorali. Preferisco un’espressione che garantisca un più alto grado di banalizzazione e indeterminatezza. Prima? Ci si chiamava tutti redattori, correttori, titolisti, linotipisti ecc., salariati o a cottimo. Almeno per questo non ho rimpianti.
Quelle di oggi sono professioni tautologiche: fai quello che fai / devi fare quello che devi fare / va fatto in un certo modo quello che va fatto a quel modo. Professioni che ancorano alla concretezza della catena lo spirito altrimenti eccessivamente baldanzoso e ottimista del redattore, e questo vale anche per il magazziniere e per il garzone delle consegne. Non è il modello fordista, ma quello dell’ottimizzazione e che prima chiamavamo romanticamente alienazione, ma non c’era twitter per ricordarcelo ogni 24 secondi. Quelle di oggi sono professioni illusorie e ricattatorie, spesso, perché spesso non avrebbe senso chiamarle “lavoro” in quanto non hanno retribuzione (così cantano insieme erinni e vestali del diritto) e altrettanto spesso “gratificano” profondamente e le paghiamo a caro prezzo. E cos’è cambiato?
Prima com’era? Le professioni culturali, come le ho conosciute io, sono tutte quelle attività, funzioni e persone che una volta ben triturate dagli ingranaggi fanno andare avanti la macina (sic.) [poteva sembrare un refuso, ma non lo è, sarebbe stato bello che fosse stato inizialmente un lapsus per poi dimostrarsi un’intuizione, ma così non è: NdR]. Nel tempo è stato sempre più evidente che “la farina del diavolo” della nostra macina è prodotta a partire dal “grano” che forniamo noi stessi. Ma cos’è cambiato? Cosa effettivamente posso rimpiangere? I modi del lavoro? La penna a sfera? La carta carbone? Gli orari inflessibili? La qualità? Il rispetto per un codice etico del redattore? Una busta paga più sostanziosa? Tempo libero? Ferie pagate? Tempo per la creatività? Pensione? Sì, effettivamente queste cose non ci sono più… ma valgono un rimpianto?
A ben pensarci, non è cambiato quasi niente: lavorare stanca, lavorare serve, un lavoro fatto bene dà emozioni. Il rimpianto, l’unico che posso avere, è che prima mi era sufficiente maledire il capoufficio, produrmi un’ulcera per una scadenza lisciata, farmi i conti in tasca e poi guardare nelle tasche del collega… ma quello era il sistema della macina, e gioco forza l’avevo accettato. L’abbiamo accettato senza farci troppe domande, tutt’al più “prendendo pose”. Adesso della nostra rabbia non abbiamo più che farcene, non possiamo permetterci il lusso di adoperarla come valvola antristress a fini conservativi (conservativi del sistema, più che del quieto vivere). Per il lavoro com’era non c’è proprio nessun motivo di provare rimpianti. Allora che si fa? Prima di tutto liberarsi dagli alibi (la cultura non finirà perché dalla cellulosa si passerà al bit) e poi farsi carico delle proprie scelte e cercare futuro.
Invece di continuare a macinare, in casa :duepunti ci si è messi riflettere sullo stato delle “cose” nostre, sul lavoro, equità, sostenibilità, sapendo che dovevamo guardare oltre, e che il “dopo” la fine del mondo-come-lo-conoscevamo è già ora (abbiamo una specie di tavolo aperto: http://www.hypercorpus.org/). I prossimi passi per noi instabili delle professioni culturali saranno quelli di smarcarci dal nostro atavico individualismo da ricattati-conniventi, ognuno se ne dovrà convincere da sé, ma sarà bene ascoltarsi di più, e riconoscersi fuori dalle categorie, dalle ottiche veterosindacali e del compromesso. Bisognerà fare tabula rasa di alcune regole (quando non si praticava il fuorigioco i ragazzini si divertivano di più). Le professioni culturali sono quelle che dovrebbero garantire a tutti un’alta qualità nel costante uso della critica dell’esistente, non della sua conservazione.
POSTILLA (altrimenti il tono è sin troppo deprimente): altre forme ci sono, si possono condividere spazi e sistemi per lavorare in modalità che sfuggono a ottiche pragmatiste aziendali e che pure rimangono concrete. Esiste la dimensione del coworking, e Palermo siamo fortunati ad essere testimoni di un primo nucleo di idee e pratiche che si stanno consolidando in Re Federico cowork (visitare per credere: http://www.coworkingpalermo.net/). E poi c’è un altro modo di pensarsi nella politica della “res publica”: molti di noi sono già il Quinto Stato (se vogliamo: http://www.ilquintostato.org/) e la “furia dei cervelli” non è necessariamente luddismo e ostentazione muscolare di rabbia passiva (cazzo! sono i nostri diritti… e saperlo serve: http://furiacervelli.blogspot.it). Soprattutto uno spiraglio a ben sperare per quelli che fanno il nostro lavoro c’è: c’è l’Osservatorio degli editori indipendenti ODEI (qui il suo manifesto: http://odei.altervista.org).
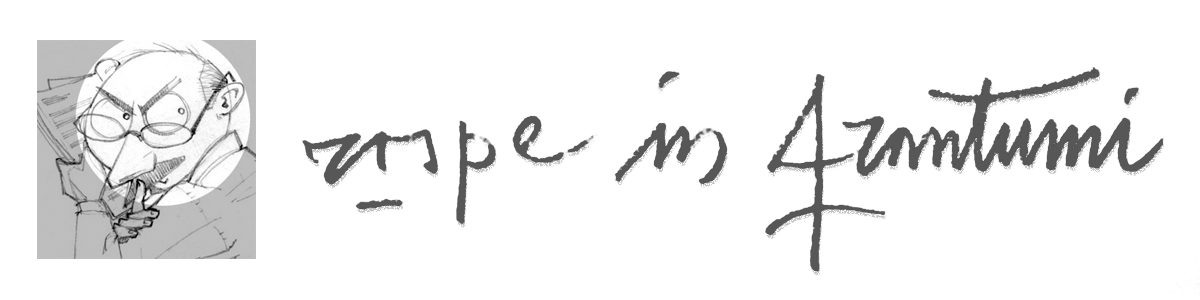













Qui un’ampia lamentatio a tema: http://www.viarigattieri.blogspot.it/search/label/lavoro